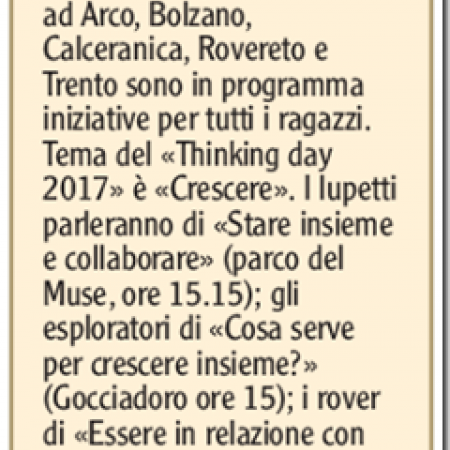Inviato da amministratore il
Come primo Presidente era stato nominato il cav. Marco Piovan, padre dell'esploratore Virgilio, morto prematuramente nei 1921, alla vigilia dei primo campeggio organizzato dalla nostra sezione a S. Giacomo sui monte Baldo. A Piovan si affiancava Alessandro Lenner ed assieme iniziavano l'attività scoutistica della sezione. In poco tempo gli iscritti raggiungevano le trenta unità. La sezione veniva riconosciuta ufficialmente dalla Sede Centrale di Roma il 6 maggio 1919.
 La prima sede si istituiva in via Tartarotti all'ultimo piano dei palazzo Todeschi, da dove passava poi in casa Baroni a fianco dei Municipio, quindi in un locale del palazzo dell'istruzione in corso Bettini e per ultimo in uno scantinato dell'istituto Magistrale in corso Rosmini, ove si metteva a disposizione dei ragazzi anche la retrostante palestra.
La prima sede si istituiva in via Tartarotti all'ultimo piano dei palazzo Todeschi, da dove passava poi in casa Baroni a fianco dei Municipio, quindi in un locale del palazzo dell'istruzione in corso Bettini e per ultimo in uno scantinato dell'istituto Magistrale in corso Rosmini, ove si metteva a disposizione dei ragazzi anche la retrostante palestra.
In questo periodo iniziale di vita della sezione, l'attività si rivolgeva, come si è accennato, ai campeggi.
Il materiale necessario, cioè tende, coperte, brandine, pentolame ecc., veniva fornito dalle truppe di stanza in città e trasportato con i loro muli e relativi conducenti, di volta in volta messi a disposizione della sezione.
Non si contano i cittadini di ogni ceto che, in un modo o nell'altro, intervenivano con aiuti di vario genere, affiancando e sostenendo l'attività della sezione. Capo Reparto era Mario Deflorian, fratello di Silvio, che in seguito, avrebbe coperto un ruolo molto importante nella sezione; Arrigo de Bertoldi di Borgo Sacco copriva la carica di Vice Capo Reparto.
In sintonia con la didattica scoutistica, durante il campeggio si svolgevano lezioni di studio dei terreno, orientamento diurno e notturno con e senza bussola, studio della flora e fauna dei luogo, preparazione di attrezzature di fortuna per il pernottamento ed il soggiorno in montagna, uso delle corde e dei nodi per arrampicata, pronto soccorso e pratica di cucina, gare di resistenza nella corsa ed in altri esercizi ginnici.
Dopo la prima felice esperienza, nel successivo 1922 si effettuava, sul monte Scanuppia, un secondo campeggio presso Malga Palazzo. Anche in questa occasione interveniva l'esercito a dare un aiuto agli scout; dirigeva il campeggio il noto professore di educazione fisica Arturo Conzatti.
Nel 1923 la sezione partecipava al campo nazionale di Andalo ed otteneva il primo premio per la costruzione di un attendamento, detto “la zeriba”.
Nei 1924 la sezione si recava ai campo nazionale organizzato in Sardegna. Nel 1925 e 1926 i campeggi venivano fatti in Serrada.
In quel periodo in sezione si sviluppava con molto interesse, oltre all'attività estiva, anche una intensa attività invernale, nei periodi delle vacanze scolastiche, grazie ad un altro benemerito dello scoutismo roveretano, Diego Costa, che metteva a disposizione dei giovani alcuni locali della sua casa di Serrada. In quelle occasioni si praticava lo sci puro, con lunghe camminate con gli sci ai piedi e poi le belle scivolare sui prati di Fondo Grande e della Martinella o fra le abetaie della zona che ancora non conoscevano io scempio delle seggiovie e degli skilift e la massiccia invasione dei così detti sportivi della neve dei giorni nostri.
I n città gli scout erano sempre a disposizione per cerimonie patriottiche all'Ossario di Castel Dante oppure al Museo Storico della Guerra. Su proposta della Croce Rossa Italiana e la sollecitazione di Antonietta Giacomelli, di Paola Orsi e di Luigina Jacob, allora dirigenti della U. N. G. E. I. , tutti gli aderenti alla sezione avevano infatti partecipato al recupero delle salme dei soldati italiani e stranieri caduti sullo Zugna e sul Finonchio, durante la prima guerra mondiale, per tumularli poi nell'Ossario di Castel Dante.
n città gli scout erano sempre a disposizione per cerimonie patriottiche all'Ossario di Castel Dante oppure al Museo Storico della Guerra. Su proposta della Croce Rossa Italiana e la sollecitazione di Antonietta Giacomelli, di Paola Orsi e di Luigina Jacob, allora dirigenti della U. N. G. E. I. , tutti gli aderenti alla sezione avevano infatti partecipato al recupero delle salme dei soldati italiani e stranieri caduti sullo Zugna e sul Finonchio, durante la prima guerra mondiale, per tumularli poi nell'Ossario di Castel Dante.
A quel tempo la divisa degli scout era molto simile a quella dei soldati di fanteria. Solamente nel 1924 fu introdotta la vera e propria divisa scout. Ciascuno, per proprio conto, doveva provvedere al camiciotto verde, ai pantaloncini di velluto marroni, ai calzettoni ed al cappellone, indumenti questi, eguali per tutti gli scout, mentre un foulard diverso distingueva lupetti, esploratori, rover, senior.
Poco dopo la nascita della sezione, al suo interno si costituì pure una Fanfara Scout ad iniziativa di Umberto Fadanelli, presidente della sezione nel 1923. La Fanfara veniva sempre accolta con entusiasmo dai cittadini quando passava per le vie davanti alle pattuglie scout.
Importante ricordare, in quegli anni, la partecipazione allo Jamboree.Internazionale svoltosi a Parigi, dei roveretani Diego Costa e Silvio Frisinghelli e di uno scout di Roma quali rappresentanti dello scoutismo italiano.
La sezione purtroppo era costretta, dagli eventi politici, a sciogliersi nel 1927 quando contava 55 iscritti effettivi. La bandiera della sezione veniva consegnata alla direzione dei Museo Storico della Guerra, con una solenne e mesta cerimonia carica di nostalgia e di bei ricordi. Pubblichiamo più avanti l'articolo apparso su “il Gazzettino di Venezia”, nei quale si riportava la cronaca di quell'importante momento.
Il periodo che seguì, fino al 1945, veniva indicato in gergo scout, il periodo della “Jungla Silente”, rifacendosi al modo di esprimersi di Kipling nel suo “Libro della Jungla”. Da allora in poi, per tutto il ventennio dominato dal fascismo, l'attività scoutistica non era più ammessa, ma gli scout roveretani la svolgevano ugualmente in modo clandestino fino al 1940. Si formava infatti una Associazione con una sigla che non lasciava dubbi: società Giovani Escursionisti Italiani. La società GEI organizzò parecchi campeggi e gite in montagna e, nella solitudine di quei momenti, i partecipanti facevano rivivere la loro passione per tutto ciò che era scoutismo. Fra loro c'erano uomini e ragazzi di ogni formazione politica e sociale, ma nessuno fece mai parola con altri di questa attività che era chiaramente contro i dettami dei potere di quegli anni e che poteva portare agli arresti chi la praticava.
Solo dopo la fine della guerra si seppe che in campo nazionale erano sorti gruppi spontanei formati dagli scout. Come riportato dal fascicolo “I Giovani Esploratori Italiani” di Fabrizio Marinelli, a Torino vi era il Gruppo Escursionisti Italiani; a Firenze il Gruppo Escursionisti indipendenti; a Trieste il Gruppo Escursionisti Indomito, di cui esiste ancora oggi la bandiera presso il Centro Forniture Scout di Milano; a Pesaro le Aquile Azzurre; a Roma il Gruppo Lupercale. Tutti questi gruppi clandestini cessarono le loro attività nel 1940, come il nostro gruppo, con l'inizio della seconda guerra mondiale.